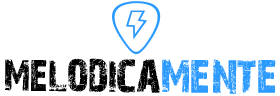Polly Jean Harvey, meglio conosciuta come PJ Harvey, è una cantautrice attenta e inquieta, che narra delle storie di questo tempo senza filtri o paure di sorta: così come è stato nel 2011 con “Let England Shake“, vincitrice di un Mercury Prize, lo è oggi con “The Hope Six Demolition Project“, suo nono album in studio per la Island Record co-prodotto da lei, Flood e John Parish.
Incidere un disco a cinque anni di distanza da un capolavoro deve essere stato abbastanza duro, ma PJ ha deciso di mettersi in gioco completamente in questo disco: accompagnata da John Parish (cori, tastiere, percussioni, tastiere e chitarre), Flood (cori e basso), Mick Harvey (cori, percussioni, slide guitar) e Jean-Marc Butty (cori e percussioni) e seguita da altre guest star come Linton Kwesi Johnson, Terry Edwards, Mike Smith, James Johnston e Alain Johannes, la cantautrice britannica si è descritta e ha descritto cosa ha visto nel suo girovagare tra Kosovo, Afghanistan e Washington D.C. insieme al fotografo/filmmaker Seamus Murphy tra il 2011 e il 2014. D’altronde il titolo dice già molto del disco: l’Hope VI Project era un progetto attivo negli Stati Uniti in cui case pubbliche fatiscenti in aree con alti tassi criminali sono state demolite per fare posto ad abitazioni migliori ma con l’effetto che i precedenti residenti non si sono potuti più permettere l’affitto e ciò ha portato a parlare di “pulizia sociale”.
Il disco è stato presentato dai singoli “The wheel”, “The Community of Hope” e “The orange monkey” ed è composto da undici canzoni per quasi 42 minuti di musica e si apre proprio con “The Community of Hope“, canzone che è stata una vera e propria pietra dello scandalo soprattutto per la zona di Washington DC dove la cantante è stata aspramente criticata per il testo che non offriva alternative parlando soltanto della situazione (e qui verrebbe da dire alla Elton John “Don’t shoot me, I’m only the piano player”). Dopo il folk iniziale ci troviamo di fronte a “The Ministry of Defence“, pezzo dal ritmo quasi da giallo noir e con Harvey che forza la sua voce verso il falsetto senza sfigurare nel tentativo parlando della guerra in Afghanistan, mentre con le atmosfere acquatiche e ovattate di “A line in the sand“ci introduce alla guerra nel Kosovo con un testo altalenante (“What I’ve seen—yes, it’s changed how I see humankind/I make no excuse—we got things wrong, but I believe we also did some good.” “Quello che ho visto, ha cambiato come io vedo l’umanità/Non ho scuse da fare – abbiamo sbagliato, ma credo che abbiamo fatto qualcosa di buono.”)
I fiati introducono “Chain of keys“, un bel pezzone corale e ritmato come solo PJ Harvey li sa fare, una marcia spirituale e carica di significato prima di uno dei pezzi più suggestivi del disco, “River Anacostia“: questo brano sembra uscito dritto da un gospel film come “Il colore viola”, con il suo ritmo lento e incalzante alla ricerca di un dio che esca dalle acque a salvarci. “Near the Memorials to Vietnam and Lincoln” è un’altra canzone che sembra venire da un altro tempo e da un altro luogo, con l’immagine di un ragazzino che lancia semi ad alcuni uccelli nel tentativo (inutile) di farli andare via ottenendo invece l’effetto opposto: è la figura letteraria della salvezza negata, che aleggia in tutto il disco.

“The orange monkey” desta un attimo di perplessità all’interno di questo disco e qualche domanda per la natura della canzone e del suo contenuto ma sono domande a cui non avremo risposta: “Medicinals” si allinea sulla stessa linea con il testo che parla confusamente di quando Washington DC era una terra usata dai nativi americani per coltivare piante medicinali. Con “The Ministry of Social Affairs” il suono torna ai tempi dei pionieri del garage rock The Sonics ed al suono della prima Seattle e il tutto viene introdotto da un pezzo tratto al singolo del 1955 di Jerry McCain “That’s what they want”, per un pezzo di denuncia sociale.
“The wheel” è la canzone più lunga del disco e parla della guerra in Kosovo, esperienza traumatica per la cantante nella quale ha assistito di persona alla gioia di un bambino in una fiera con poco distanti le foto sbiadite dal sole dei bambini uccisi per pulizia etnica (di cui parla nella canzone: “Now you see them, now you don’t””Ora li vedi, ora non li vedi più“) mentre con la canzone di chiusura “Dollar, dollar” si parla dei bambini che chiedono l’elemosina in Afghanistan (ma non bisogna fare migliaia di chilometri per vedere una scena del genere, possiamo assicurare PJ).
“The Hope Six Demolition Project” è un grande punto interrogativo: è un disco che parte benissimo e finisce stentando, almeno per quanto riguarda i testi. Per quanto concerne la musica, invece, siamo di fronte ad una sorta di lungo documentario musicale di tutta una serie di situazioni descritte dal fotografo Seamus Murphy e sembra che questo sia un lavoro concluso di fretta e furia, con ancora del lavoro lasciato in sospeso… e questo sembra onestamente assurdo, visto che di tempo PJ Harvey ne ha avuto, ben cinque anni, prima di pubblicare questo disco. Questo album va visto come una sorta di reportage musicale via chitarra, sassofono e gospel di una serie di situazioni di disperazione e di abbandono da parte della società che dimentica le tragedie che non sono sotto casa. Ci sono tante reminiscenze musicali tra Bad Seeds e garage rock, glam e blues, ma è la lettura che lascia un attimo interdetti, con un meccanismo di sovrastima di quello che Harvey ha vissuto in Afghanistan, Kosovo e Washington. “The Hope Six Demolition Project” è un disco che funziona perfettamente a tratti e anche quando non funziona è comunque un album molto godevole che riesce a sopperire alla pochezza dei testi con la grandezza della musica. Brava ma non bravissima PJ.