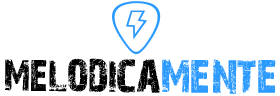Direi che è accezione comune il fatto che questo sia stato un annus horribilis per le tanti morte che si sono susseguite con cadenza quasi mensile nel mondo della politica, del cinema, dell’arte e della musica. È purtroppo notizia di queste ore la dipartita di Leonard Cohen, grandissimo musicista e poeta canadese, appena ad un mese dall’uscita del suo ultimo disco “You want it darker“, il suo tredicesimo album in studio e il ventiquattresimo di una lunga carriera cominciata nel lontano 1967 con “Songs of Leonard Cohen”.
Parlare dell’impatto che ha avuto la musica di Cohen sulla cultura internazionale (compresa quella italiana) è molto facile: basti pensare che due delle sue più note canzoni, “Suzanne” e “Hallelujah“, quando sono state cantate da altri interpreti sono diventate dei piccoli capolavori (basti pensare alla versione di “Hallelujah” di Jeff Buckley, forse la più bella in assoluto). Anche in Italia Il Maestro canadese ha avuto tantissimi estimatori che hanno tradotto le sue canzoni, da Francesco de Gregori a Fabrizio de Andrè passando per Claudio Daiano e Francesco Baccini.
È quindi con il cuore colmo di tristezza e conscio della pesante eredità lasciata dall’82enne songwriter che mi appresto a parlare del suo ultimo disco, questo “You want it darker” prodotto per la Columbia e composto da appena nove canzoni. L’ultimo capitolo della vita musicale di Cohen ha ricevuto in giro per il mondo recensioni entusiastiche e dopo l’ascolto non faccio fatica a capire perchè: prodotto dal figlio Adam Cohen, il nuovo e sorprendente disco di Leonard si apre con la title-track che esplora la sua religiosità laica (come lui ha spesso dichiarato nelle sue interviste) in una canzone molto d’impatto grazie anche all’apporto del coro Cantor Gideon Zelermyer & the Shaar Hashomayim Synagogue Choir di Montreal, che con le loro voci evocano i suoni con cui Leonard è cresciuto. Colpisce soprattutto una frase del ritornello: “I’m ready my Lord“. Viene subito in mente “Lazarus” di David Bowie, altra grave perdita musicale recente, con la sua “Look at me, I’m in Heaven“, e lascia stupiti la capacità di questi artisti di dettare il loro testamento musicale ben sapendo o sentendo di essere arrivati al termine del loro viaggio terreno. Una lucidità che ha quasi del soprannaturale, sicuramente del mistico.

Con “Treaty” siamo in pieno nel perfetto stile Cohen, quello di un vecchio crooner che ammette l’egoismo insito nell’amore e la speranza di porvi rimedio in qualche modo, forse mettendosi a nudo grazie al suo pianoforte impreziosito dagli archi di sottofondo: sulla stessa falsariga troviamo “On the Level“, una canzone che parla del desiderio visto dagli occhi di un uomo anziano dove fa capolino una chitarra e il coro ma dove in prima fila c’è sempre lui, il buon vecchio Leonard con la sua voce presente ma mai ingombrante, mentre “Leaving the Table” è una stupenda ballad che si muove tra gioia e dolore impreziosita da un assolo di chitarra incastonato nel pezzo.
Ascoltare questo disco è quasi come essere catapultati in un altro luogo e in un’altra epoca e lo dimostrano canzoni come “If I Didn’t Have Your Love“, una classica canzone d’amore lenta e avvolgente che non si cura del tempo ma che regala 3 minuti di pura magia (“That’s how broken it would be/what the world would seem to me/if I didn’t have your love to make it real.” “Sarebbe proprio a pezzi, il mondo sarebbe così per me, se non avessi il tuo amore che lo rende reale”). Subito dopo però troviamo “Traveling Light“, una canzone che parla di un uomo che parte per un viaggio alla ricerca di qualcosa e trova la gioia della solitudine, un altro tassello di questo testamento musicale, però stavolta più triste, quasi rassegnato. Questa sensazione permane anche ascoltando “It Seemed the Better Way“, che più che una canzone sembra una preghiera, una di quelle che si conoscono da sempre ma che stavolta non riescono a regalare quel conforto che erano solite dare.
Andando avanti nell’ascolto, se si potesse riassumere questo disco in una sola parola credo che il termine giusto sia “tristezza”: “You want it darker” è un album intriso di malinconia, dolore, rassegnazione e ricordi, tutte quelle cose che affollano la vita di un uomo quando si rende conto di essere arrivato alla fine del suo cammino e si guarda indietro per capire cosa ha costruito e se la sua vita ha avuto davvero un senso. Per fare una scelta del genere e per rendere palese queste emozioni ci vuole coraggio, lo stesso coraggio che si trova in una traccia come “Steer Your Way“, una canzone che parla del coraggio che afferra il cuore nel momento in cui lo stesso si sta addentrando nelle tenebre sconosciute davanti a lui. E dopo questo brano, l’addio migliore non poteva che essere “String Reprise/ Treaty“, una rivisitazione per quartetto d’archi di “Treaty”, un momento di profonda emozione che si conclude con la voce di Cohen “I wish there was a treaty between your love and mine”, “Vorrei che potessimo firmare un contratto tra il tuo amore e il mio”. Voglio concludere questa recensione (anche se più che una recensione è stato un vero e proprio cammino nel cuore di un uomo che sa di essere arrivato alla fine) con le parole di “Traveling light“: “Viaggio leggero, au revoir, un tempo era così luminosa, la mia stella che ora non brilla più.” Che la terra ti sia lieve, Leonard.