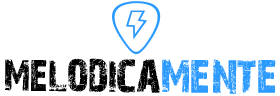Ci troviamo davanti un disco che, se non conoscessimo l’origine dei componenti, definiremmo internazionale, non che il fatto che essi siano italiani faccia scemare la qualità del disco, anzi, accende ancor più la curiosità di scoprire cosa il nostro ambiente musicale può offrire. Gli Hate Boss propongono una musica che ha ben poco da spartire con la tradizione della musica italiana e, la loro scelta, è sicuramente forte e ben visibile fin dall’inizio. Un esordio della formazione proveniente da Treviso proprio grazie a “Time Of The Signs”, disco composto da nove tracce che riescono immediatamente a dare una forma a questo prodotto discografico che assume una maturità sicuramente da tenere sotto controllo. Prima di inoltrarci nella vera e propria recensione di questo lavoro, diamo alcune note introduttive anche solo per coloro che si domandano, “Ma chi sono gli Hate Boss?” La band stessa ha definito questo album partendo dal titolo che è un omaggio al disco di Prince.
La formazione spiega che quello dei segni, intesi in modo molto generale, è il filo conduttore di questo lavoro che si impone come un esordio sicuramente molto interessante. Definire gli Hate Boss in un solo genere musicale è molto difficile come lo sta diventando sempre più per la maggior parte delle band del nostro paese, quelle magari più di nicchia, quelle che vivono una situazione di emigrazione proprio perché i dogmi italiani hanno sempre e solo una mentalità musicale. Ma, questo è un altro discorso che esula dalla recensione di “Time Of The Signs“, uscito il 30 marzo presso la Redled Recors e distribuito da Venus. La formazione ha deciso di proporsi al pubblico proprio con il singolo che dona il nome all’intero disco e che, ancora una volta, si riferisce ai segni, concetto molto caro alla band.
Hate Boss: alla scoperta della band trevigiana

Ci troviamo davanti ad una formazione molto giovane, nata nel 2010 nella provincia di Treviso, a Conegliano, la band ha pubblicato inizialmente un primo EP dal titolo “So Much” e il singolo “Get Out” che ha visto la collaborazione di Tommaso Mantelli. Sfogliando fra il background degli Hate Boss si scoprono alcune aperture di concerti sicuramente da segnalare come quelle dei Motel Connection, Does It Offend You Yeah? e molti altri. Siamo in terreno quasi puramente elettronico e, questo emerge immediatamente. Si sente fin dopo pochi secondi dal “Play” del disco. Ci immaginiamo, se non lo sapessimo, gli Hate Boss in qualche sobborgo di Berlino o di qualche grande cittadina europea, per non richiamare sempre la ovvia America, invece la band è tutta italiana ed è composta da Mattia “Low” Tomasi (voce – basso – synth), Simone “Zacca” Zaccaron (chitarra – synth), Emanuele “Ema” Lombardini (batteria) e Alessandro “Ale” Tomasi (elettronica – synth). Non è difficile individuare gli amori musicali dei quattro giovani: si capisce una influenza elettronica, punk funk, dance che si spalma oltre gli orizzonti e le limitazioni dei generi.
Gli Hate Boss hanno parecchia gavetta alle spalle, si sente ma soprattutto si percepisce in un suono nato proprio per i locali ed è lì dove la band ha preso forma, dove la formazione non ha mai smesso di essere presente. Un disco fatto per ballare, fatto per divertirsi con la sperimentazione e una eterna ricerca del suono.
Hate Boss: “Time Of Signs”, l’analisi del disco
Iniziamo a vedere “Time Of The Signs” proprio dalla tracklist:
- Palm Beach
- Shapes
- Time of the signs
- Decode
- Age of flames
- Monkey
- Kim Peek
- Brighter
- Sailing

Hate Boss - "Time of the signs"
1. “Palm Beach”: il disco si apre con un brano potente. Ci troviamo davanti una canzone costruita per far ballare. La stessa band parlando di questa canzone racconta come è nata quasi in modo casuale innanzitutto trovando il tema ossessivo di questo brano e aggiungendogli un ritmo sincopato dance hall, condito con chitarre che sottolineano proprio la volontà di costruire un suono definito e pieno. “Palm Beach” non ha altri fini se non quello di trovarsi in una pista per ballare senza tanti pensieri.
2. “Shapes”: questo brano è ammaliante e seducente. Ci troviamo davanti ancora una volta una chitarra ben udibile ma che in questo brano ha un ruolo quasi peculiare. Un brano che porta ad essere maggiormente “capito” rispetto la martellante “Palm Beach”.
3. “Time Of The Signs”: non si fatica a capire come mai sia stato scelto questo brano come singolo dell’intero disco. Il fulcro del testo, manco a dirlo, sono ancora una volta i segni, proprio quei segni che invitano ad essere seguiti, ad essere presi con la dovuta dose di coscienza. E’ un brano che quasi si snoda fino ad un certo punto per poi rimanere in sospeso. Ci troviamo immersi in una melodia anche molto cantabile, e, non dimentichiamolo, stiamo parlando comunque sia di musica elettronica. Un singolo che sicuramente fa alzare l’attenzione.
4. “Decode”: probabilmente questa canzone non spicca per originalità ma scorre liscia come non mai posizionandosi fra una delle canzoni maggiormente riuscite della formazione. “Decode” dimentica almeno per la prima parte del brano quella dance schiacciante delle canzoni che la precedono per poi salire in un ritornello martellante che però subito viene unito ad una strofa che è sicuramente accattivante ma non troppo spinta. C’è un connubio molto interessante in questo brano che probabilmente ha anche la mira di distinguersi dal resto delle canzoni presenti nel disco e, ci riesce molto bene.
5. “Age Of Flames”: ancora una volta è la musica che crea un senso complessivo alla canzone. Non che la voce non abbia alcuna importanza, anzi, si adegua e dà vita ad una sperimentazione ancora tutta da scoprire e definire, donando un senso proprio aggiuntivo alla canzone ma, in questo brano emerge pesantemente la strumentalità della formazione.
6. “Monkey”: il brano risulta essere un tentativo. Sicuramente non può essere utilizzato né come simbolo né tanto meno come bandiera degli Hate Boss. Ancora una volta emerge una sperimentazione di campionamento, di synth, effetti che trovano un senso proprio una volta che prendono vita. Il brano è stato curato da Tommaso Mantelli che, ha un ruolo preponderante in una delle formazioni più discusse del nostro paese, niente meno che Il Teatro degli Orrori. “Monkey” non fatichiamo ad immaginarcela durante uno show con gente che canta sì ma soprattutto balla senza freni.
7. “Kim Peek”: la band ha spiegato questo brano innanzitutto come testo. La canzone si basa su Kim Peek, forse il più conosciuto Savant (idiota sapiente) della storia dove con questa parola ci si riferisce alle persone che sono afflitte dalla patologia di ricordare tutto (il riferimento al personaggio di “Rain Man” è ovvio). Fa sicuramente un effetto positivo ritrovarci davanti, forse per la prima volta, ad una preponderanza della voce, questa volta. C’è un vero testo e ben costruito, dietro alla musica, da raccontare e, questo emerge fin da subito anche se, ovviamente, i suoni tanto cari alla formazione non vengono di certo dimenticati.
8. “Brighter”: un brano che viene rappresentato da un’altalena di suoni. Vi sono parti rilassate, quasi composte, quasi raccontante che subito si tuffano in musica potente ed esplosiva, a tratti addirittura liberatoria.
9. “Sailing”: ce lo si aspettava un pezzo solo strumentale, ed eccolo proprio a chiusura del lavoro. La band stessa ha definito questo brano un “riassunto” di una sperimentazione che in realtà era molto più lunga, ben quindici minuti di psichedelia senza un gran senso ma affascinante.
Ci troviamo davanti, dunque, in conclusione, a nove tracce che sanno ammaliare. Ovviamente, deve piacere il genere, altrimenti, sarà ben difficile assaporare ciò che gli Hate Boss vogliono trasmettere con la loro musica. Come non pensare che, ancora una volta, l’Italia vanta band con tanto di gavetta alle spalle, che propongono un sound che ha convinto gente come quella sopracitata che li ha invitati ad aprire i loro show, ma per i più sconosciuta. Eccoci davanti ad un pezzo d’internazionalità italiana.
Voto: Dite la vostra!