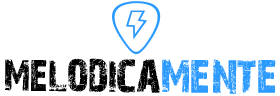Probabilmente questo 2013 deve essere un anno particolare se, dopo il ritorno dei Deep Purple, ci troviamo a parlare del ritorno dei mitici Black Sabbath. Sissignore, avete letto bene. I Pionieri del Metal sono tornati con una nuova fatica discografica, “13“.
E potremmo anche dire che ci sono proprio tutti, dato che la formazione è quella davvero storica, visto che manca solo il batterista Bill Ward (sostituito da Brad Wilk dei Rage Against the Machine).
Il disco, prodotto Rick Rubin (l’uomo di fiducia dei Red Hot Chili Peppers ed operatore di resurrezioni con band come Johnny Cash, AC/DC, Aerosmith, Metallica e ZZ Top), è composto da 8 brani (più tre bonus tracks nella Deluxe Edition, “Methademic“, “Peace of Mind” e “Pariah“) che durano quasi 54 minuti. Quindi, se siete per le canzoncine piccole e veloci, questo potrebbe non essere il disco per voi. E potrebbe non esserlo anche se non amate il metal duro e puro da anni Settanta, visto che la band ha deciso di ripescare proprio da quel suo background musicale immenso che sono i primi anni di vita.
Il disco è un prodotto che sembra uscito pari pari dal vecchio libro alchemico di Geezer Butler e Tony Iommi, viste le alchimie musicali di cui è composto e che si mostrano appieno già nella prima traccia, “End of the beginning“, una simil-suite da 8 minuti a struttura circolare con la solita voce da stregone di Ozzy Osbourne che ironicamente canta di fini e di inizi. Ironia a profusione ed arpeggi da film horror caratterizzano “God is dead? “, altro pezzone strumentale di quasi 9 minuti che sembra uscito dalla colonna sonora di un film di Sam Reimi.

La missione di Rubin e dei Black Sabbath era quella di tornare allo stampo originario musicale del gruppo dopo quasi 43 anni di distanza dall’uscita di “Paranoid” senza però sembrare una copia sbiadita e senza pathos di se stessi. Posso dire che il risultato è più che accettabile alla fine, visto che i nostri suonano credibili anche alla soglia ormai dei settant’anni e che il disco ha un suo corpus ben preciso. Le chitarre ci sono, il basso pure, la voce di Ozzy Osbourne sembra in forma e anche senza acuti è sempre lui il cantante (ascoltare “Loner” per capire cosa intendo dire).
L’album prosegue con qualche episodio più movimentato (“Live forever” e “Dear Father“) e tendente al blues (“Damaged soul“) dove Tony Iommi fa quello che gli riesce meglio da una vita, ovvero sparare riff come un Dio della chitarra. E se mettiamo “Zeitgeist“, una ballad copia di “Planet Caravan“, una ballata come solo i Black Sabbath sanno fare, direi che il quadro è completo.
“13” ha un difetto, cioè quello di essere un po’ troppo “lento”, ovvero di non premere molto sull’acceleratore ma di basarsi su grandi riff di chitarra e maestosi giri di basso, denotando un’assenza di “sporco”, di graffi, di sudore. Ma ormai sono passati troppi anni da quel lontano 1970, troppe persone sono scomparse (R.I.P. Ronnie James Dio e Bill Ward), troppi guai sono successi (problemi di salute di Iommi, la voce di Ozzy che va e viene) e forse era anche chiedere troppo, come ha affermato giustamente in alcune interviste Ozzy Osbourne dicendo che questo disco era nato ora perché sarebbe stato impossibile farlo tra qualche anno per motivi di vecchiaia.
Ozzy scrisse nel 2009, nella sua autobiografia, che l’unica ambizione che gli era rimasta era quella di avere un album al numero uno della classifica americana. Grazie all’esordio al primo posto della Billboard, direi che questo è il miglior regalo di addio che potesse desiderare. Perché di addio si tratta, almeno a mio parere, dato che questo disco suona tanto come un testamento in musica. Ci sarebbero tante cose da dire, ma l’ultima canzone è esemplare e le dice per me: quei rintocchi di campana segnano che il sipario sui Black Sabbath cala qui, dopo 43 anni di onorata carriera. Grazie di tutto ragazzacci.