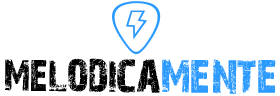Prima che arrivassero gli Arctic Monkeys in Inghilterra l’indie rock aveva avuto come padri i The Libertines, come figli i Franz Ferdinand e come nipoti i Bloc Party. Questi ultimi, nati a Londra, erano un curioso e ben riuscito esperimento musicale formato dal cantante e chitarrista Kele Okereke, dal secondo chitarrista Russell Lissack, dal batterista Matt Tong e dal bassista Gordon Moakes. Il gruppo ha prodotto album molto interessanti e canzoni decisamente sopra la media (ne cito solo uno: “A weekend in the city“) prima di affondare lentamente per frizioni tra i membri del gruppo e qualche problema di troppo con la cocaina.
Ora, a distanza di quattro anni dal loro ultimo disco, “Four“, i Bloc Party tornano sulla scena con un nuovo disco, “Hymns“, il loro quinto album in studio, e con una formazione rinnovata, avendo sostituito il batterista Matt Tong e il bassista Gordon Moakes con Louise Bartle e Justin Harris. Rimango sempre i due pilastri del gruppo, Okereke e Lissack, e rimane anche un certo archetipo musicale che li ha caratterizzati dopo un lungo periodo di sperimentazione elettronica sia nel disco precedente che in quello ancora prima, “Intimacy”. Il disco, lanciato dai suoi tre singoli “The Love Within“, “The Good News” e “Virtue“, ha avuto recensioni contrastanti e uno scarso successo commerciale. E ascoltandolo non fatichiamo a capire perchè.
Dopo quattro anni e tutto quello che è successo, questo disco poteva essere una sfida per rilanciarsi e un nuovo inizio per non affondare nelle acque dell’anonimato e ripartire come una sorta di Bloc Party 2.0. Purtroppo l’operazione non riesce moltissimo, visto che buona parte del disco deriva dalle mani di Kele che ha pescato a profusione nel suo percorso da solista dove ha usato, anzi abusato direi, dell’elettronica, e troviamo questa direzione anche nel nuovo disco del suo gruppo. Pare che si sia persa quella straordinaria capacità dei Bloc Party di incorporare al loro interno vari generi musicali e rimanere comunque loro stessi, come evidenziato in “Intimacy“, dove l’elettronica si mescolava con il punk e il grunge creando canzoni trascinanti e memorabili. Il cambio di formazione ha portato anche uno sconvolgimento a livello di testi, con Okereke che parla e medita di sesso, droghe e religione, cosa che faceva anche nella sua carriera solista.
Cosa salvare delle undici tracce di questo disco? Qualcosa da salvare c’è, assolutamente. Saltando a piè pari i primi due brani, “The love within” e “Only he can heal me“, dalla struttura simile e dominati dalla beat unit e dall’elettronica, passiamo al pianoforte di “So real“, pezzo che ricorda da vicino un altro disco dei Bloc Party, “Silent alarm”, grazie al suo lo-fi e al suo deep house: il rock fa capolino nel disco grazie alle chitarre ritmate midtempo di “The good news” pezzo che assomiglia a qualcosa dei Blur e che si mostra uno dei migliori del disco.

L’album prosegue con forse il suo brano migliore, “Fortress“, una ballad molto potente e dilatata che mostra come i vecchi Bloc Party esistano ancora in qualche modo: “Different Drugs‘” richiama i grandi picchi emotivi che i Bloc Party riescono a raggiungere con le loro canzoni e “Into the Earth” è il secondo brano dichiaratamente rock di tutto il disco, grazie alle sue chitarre sgraziate e ad un ritornello molto catchy.
Con “My true name” torniamo alle melodie evocative che hanno reso famoso questo gruppo, grazie ad una ballad atipica che varia tempo e ritmo e che riesce a colpire nel segno: purtroppo con “Virtue” il disco torna a scendere nel piattume iniziale, seguito a ruota da “Eyes“, che suona come una grande incompiuta: la melodia in alcuni tratti è davvero bella, ma la canzone non ha un senso logico che ne sia uno per poterle apprezzare. “Hymns” si chiude in “bellezza” con “Living lux“, canzone organo e voce che si perde con un effetto cosmico e di cui non ti ricordi niente appena qualche minuto dopo averla ascoltata.
In questo disco dei Bloc Party manca qualcosa: sarebbe facile dire la voglia di rischiare o la capacità di sperimentare o riabbracciare il proprio cammino musicale, ma io invece punto il dito su qualcosa di molto più importante: l’anima. “Hymns” non sembra avere anima, in alcune canzoni sembra un disco fatto per riempire un vuoto di quattro anni fa lasciato da “Four” e riempito con le dissertazioni filosofiche di Okereke, lasciando così il gruppo in una pericolosa deriva tra un nuovo possibile inizio e il prosieguo di un percorso musicale già tracciato da anni: questa condizione da asino di Buridano musicale fa sì che l’identità del gruppo, che prima ne era il suo tratto distintivo, ne esca irrimediabilmente compromessa.